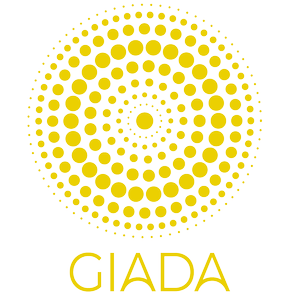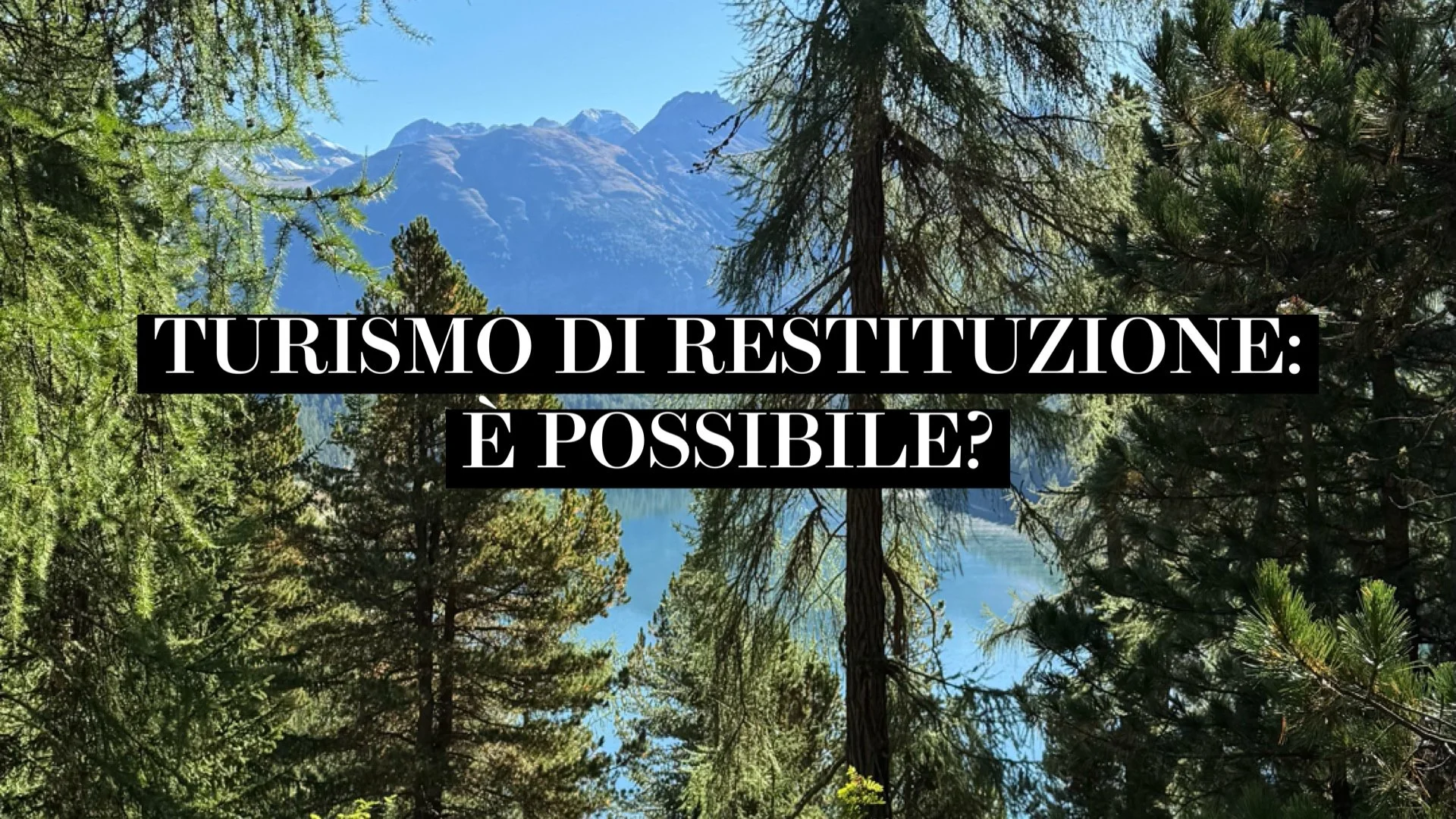Vivo in uno dei luoghi più turistici delle Alpi. Qui la montagna è ogni giorno attraversata da chi la scala, la fotografa, la abita per poche ore o pochi giorni. Io la amo profondamente, non a caso mi sono trasferita qui, e spesso mi sono ritrovata a chiederle: come posso prendermi cura di te?
La mia ricerca personale e artistica si concentra su una parola sola: il legame. Credo che sia il collante laico capace di restituire senso e unità in un tempo che spesso frammenta, disorienta e divide. Ho così provato ad applicare il legame all’ospitalità, e ne è nata un’idea di turismo di restituzione. Sarebbe un modo di abitare i luoghi che non si limita a viverli o consumarli, ma che li riconosce, li ringrazia e li custodisce, generando valore.
Da dove nasce l’idea
Negli ultimi mesi ho ulteriormente approfondito il tema del legame – tra persone, luoghi e narrazioni collettive – a cui ho dedicato l’intera tesi di Master. Ho intrecciato le intuizioni di Hartmut Rosa sulla risonanza con quelle di Mircea Eliade sul sacro. Mi sono chiesta: è possibile applicare questi sguardi al turismo, e in particolare a quello di montagna? Non inteso come turismo religioso, né solo come turismo sostenibile, ma come esperienza capace di restituire senso, cura e gratitudine.
All’inizio avevo pensato alla parola “risonanza”, ma la restituzione reputo sia un passaggio in più. La risonanza è l’esperienza che ci tocca e ci cambia, la restituzione è il modo in cui la custodiamo e la onoriamo. Non significa lasciare qualcosa di fisico al luogo, ma restituirgli dignità attraverso rispetto, attenzione e cura. È un atteggiamento interiore e morale: non trattare ciò che incontriamo come sfondo, ma riconoscerlo come presenza viva con cui siamo in relazione.
Cos’è il turismo di restituzione
Il turismo di restituzione parte da un presupposto semplice: ogni viaggio non è un prelievo, ma uno scambio. Se un luogo mi accoglie, io posso restituirgli attenzione, cura e memoria. Restituire alla montagna non significa soltanto proteggerla, ma anche riconoscerla come interlocutrice, entrare in dialogo con i suoi silenzi, i suoi ritmi, la sua fragilità. Il turismo di restituzione, in pratica, significa creare un legame. Ci sono io ma ci sei anche tu. Siamo un noi.
Anche la nominazione – quell’arte di dare voce alle cose, di raccogliere istanti e parole dal reale – diventa parte di questo gesto: nominare significa infatti riconoscere, e riconoscere è già un modo di restituire.
È un modo di abitare che non si limita a ridurre l’impatto (come spesso fa il turismo sostenibile), ma che genera valore: lascia tracce di gratitudine, rafforza l’identità dei territori, crea esperienze trasformative per chi viaggia. E a differenza del turismo religioso, non cerca mete sacre da venerare, ma riconosce la dimensione sacra che abita i gesti quotidiani e i luoghi stessi. Per la montagna, questo significa non essere trattata come risorsa da sfruttare o sfondo da consumare, ma come interlocutrice viva: una presenza fragile e potente insieme, capace di ricevere cura e restituire senso.
Il ruolo di Chesa Altrova
Con Chesa Altrova sto cercando di dare forma concreta a questa visione:
una casa che non sia solo alloggio, ma laboratorio del legame,
l’esperienza incarnata del turismo di restituzione
un luogo in cui ogni ospite possa lasciare tracce (parole, istanti, gesti di cura) che diventano memoria condivisa,
un’esperienza che intreccia arte, accoglienza, nominazione e amore per la montagna.
Uno spazio aperto
Il turismo di restituzione non è un modello chiuso, ma un campo di possibilità. Vorrei che diventasse una pratica condivisa, applicabile in contesti diversi: case, rifugi, comunità, territori che scelgono di non consumare i luoghi, ma di restituirli al mondo con nuova forza.
Questo articolo è solo un primo passo. Continuerò a esplorare, scrivere e condividere perché credo che la montagna e i luoghi che amiamo meritino non solo la nostra presenza, ma la nostra restituzione.
Ti piacerebbe contribuire a questa riflessione? Cosa significa per te restituire invece di consumare? Quale gesto di gratitudine hai lasciato in un luogo che ti ha accolto?
Raccontamelo nei commenti o scrivimi: ogni esperienza è un seme che può far crescere questo modo diverso di abitare i luoghi.